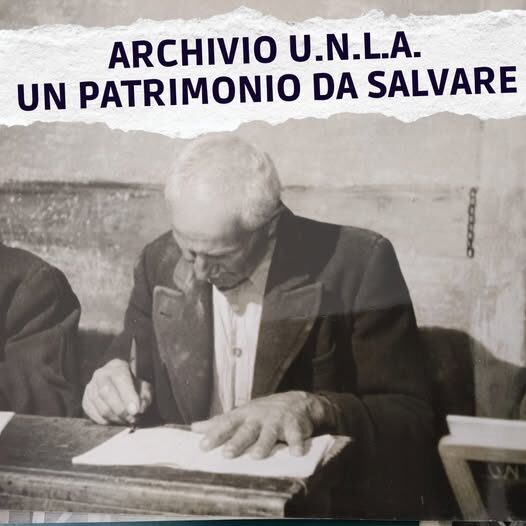(AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2025
(AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2025L’UNLA e la lotta contro l’analfabetismo. Da suddito passivo a responsabile
L’anno 1945 segna la fine della Seconda guerra mondiale. Con la creazione delle Nazioni Unite e dell’UNESCO, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, ha avuto inizio l’opera di riconciliazione e di ricostruzione, un ripensamento profondo dei valori, dei doveri che sono alla base della vita sociale. Diritto fondamentale proclamato dalla Dichiarazione Universale è l’istruzione perché cittadino, tra l’altro, dà a ciascun individuo una chiara coscienza della propria dignità di uomo e dei mezzi per raggiungerla compiutamente; l’educazione prepara gli individui a partecipare ai cambiamenti di una società sempre più complessa e a migliorare le relazioni tra i popoli, in un clima di solidarietà intellettuale e morale dell’Umanità. La presa di coscienza dei limiti dei modelli e dei sistemi ereditati dal passato, concepiti per uomini diversi, in una società diversa, pone l’esigenza di iniziative didattiche a carattere permanente che, alle diverse età, favorisca un costante arricchimento in tutti i campi del sapere e un esercizio dei diritti e dei doveri del cittadino in maniera adeguata alle esigenze del tempo in cui vive, in un visione educativa che mira ad una educazione internazionale, globale, interculturale. Compito dell’educazione doveva essere anche la costruzione della pace. una pace che fosse un processo, non un avvenimento. Se l’educazione e la vita al limite coincidono, se l’educazione di fatto è permanente, allora avrà valore educativo qualsiasi iniziativa che fornirà all’individuo nuove esperienze e nuovi stimoli, soprattutto se essa non sarà occasionale, ma consapevolmente orientata.
La nascita dell’UNLA, il 2 dicembre 1947, su iniziativa di studiosi di altissimo profilo (suo primo Presidente è stato Saverio Nitti) con l’obiettivo di creare un movimento popolare di carattere culturale per la lotta contro l’analfabetismo tra le popolazioni del Mezzogiorno d’Italia, va inquadrata nel clima generale della ricostruzione postbellica, non solo sul piano materiale, ma anche, soprattutto, su quello culturale, sociale, morale e spirituale. L’unione è stata fondata per venire incontro all’incapacità del 13% degli italiani di leggere e scrivere; all’epoca il 59,2% della popolazione non aveva neppure la licenza elementare. I “Maestri” dell’UNLA furono, per affermazione di Maria Montessori, i più diretti cooperatori alla ricostruzione sociale basata sui “Diritti dell’Homo “. Fin dalla sua fondazione, ad opera della pedagogista ed illustre studiosa Anna Lorenzetto, il rapporto tra noi e gli altri è sempre stato, in via prioritaria, uno dei valori fondamentali, come pure garantire a tutti il diritto all’educazione, per preparare gli individui al cambiamento di una società sempre più complessa e assicurarle i vantaggi di un sempre più vasto potenziale di intelligenze, di talenti, di energie. Per altro, a completamento della preparazione di base, nei Centri dell’UNLA erano presenti una tipografia, laboratori ed officine dove era possibile imparare un mestiere spendibile nell’immediato, a servizio della società. La trasformazione della società, obiettivo prioritario del movimento per l’alfabetizzazione superava la prassi di affrontare la lotta all’analfabetismo con corsi scolastici di pochi mesi e un apprendimento strumentale del leggere e scrivere. Nel gennaio 1948 fu aperto il primo Centro di Cultura Popolare “Tor di Quinto” che dal 1983 si chiama C.C.E.P Raffaele Carnevale; su richiesta del Provveditore agli Studi l’UNL A istituì 37 Centri di Cultura Popolare, concentrati soprattutto nel Mezzogiorno. I promotori della nascita dei Centri erano guidati dalla convinzione di fondo che nel Mezzogiorno e nelle isole e in genere in tutte le aree di sottosviluppo era necessario unire la lotta contro l’Analfabetismo, il semianalfabetismo e l’istruzione professionale, nel quadro di una larga opera di cultura popolare, di cultura civica e democratica. Il dramma del sottosviluppo non è dato solo dalla situazione economica o dal diffuso analfabetismo, ma dai problemi più gravi che esistono prima dell’alfabeto e che lo seguono: problemi di cultura, di educazione democratica, di inserimento nella vita della società moderna. Da qui la polifunzionalità dei Centri, la possibilità dell’incontro tra l’alfabeto e l’analfabetismo, tra un alfabeto minore quale strumento del leggere e dello scrivere e l’alfabeto maggiore, quale conquista del sapere, del lavoro, della cultura, alfabeti caratterizzati da un’impronta internazionale, ma anche da una struttura locale che derivava ai Centri dalla loro democrazia interna, una democrazia diretta. Ogni Centro è diverso dall’altro perché frutto del lavoro fatto in prima persona da persone diverse e perché profondamente radicato nell’ambiente in cui nasce; diversi sono i problemi fondamentali della loro vita, del loro lavoro, dei loro paesi. Se l’educazione e la vita, al limite, coincidono, se l’educazione di fatto è permanente, allora avrà valore educativo qualsiasi iniziativa che fornirà all’individuo nuove esperienze e nuovi stimoli, soprattutto se essa non sarà occasionale, ma consapevolmente orientata. L’azione svolta dall’UNLA è testimonianza di una ricerca e progettualità pedagogica ed educativa che non ha precedenti nella storia e rappresenta, nel suo insieme, una nuova poderosa sintesi di tutto quanto le teorie pedagogiche precedenti avevano prodotto. Si faceva riferimento non solo all’istruzione, ma anche alla dimensione mentale e spirituale che aprisse l’uomo alla conoscenza di “un nuovo modo di essere al mondo”, un modo nuovo di pensare il rapporto dell’uomo con il tempo educazione, una educazione che deve durare tutta la vita senza che la si debba limitare ad una età resa abituale dalla tradizione. Del resto la “vis educativa” e la “libido sciendi”, scaturiscono dalla natura stessa dell’uomo, quale desiderio di un sempre più vasto e, soprattutto, strutturato conoscere. L’educazione permanente nel senso di “durata”, cioè di “continuità del processo della vita interiore”, di “continuità nel permanere”, scaturiscono dai principi dell’Umanesimo, dall’evoluzione della società e dalla riflessione psicologica. L’uomo senza cultura è necessariamente limitato nella sua visione del mondo e nella sua comprensione delle varie questioni pubbliche. Le sue prerogative di cittadino sono esercitate entro limiti estremamente ridotti. Da qui la necessità di nuovi saperi, nuovi linguaggi, idonei a prevenire e contrastare i diversi analfabetismi che non sono solo dati statistici della società di oggi, ma una risultante storica. E’ la passività intellettuale che ha posto barriere tra gli uomini a trovare il modo di superare le sedimentazioni operate dall’abitudine nella scuola e nella vita sociale. L’azione dell’UNLA è stata giustamente definita il primo esperimento italiano di Educazione Permanente La concezione di una educazione nuova “rivoluzionaria”, una proposta educativa destabilizzante, per l’assetto istituzionale, apportava modifiche sostanziali al ruolo tradizionale dell’educazione, poneva in crisi l’“autorità”, “il dittatore esterno” perché doveva tendere a “trasformare” il mondo”, non più a conoscerlo e a codificarlo, rifuggendo dall’astrattismo teorico. Questo è possibile solo attraverso un generale ripensamento del processo educativo e delle teorie educative che lo sostengono, una pedagogia e una didattica al servizio della scuola e del suo legame con le concrete quotidiane esperienze delle persone, una nuova cultura in grado di fare della prospettiva di “trasformare il mondo”, del ruolo della pedagogia della vita interiore” una “vivente disciplina della scuola”, assumendo, il ruolo di protagonisti nella realtà in cui si vive, attraverso un atteggiamento mentale orientato ad una trasformazione interiore mediante la quale l’uomo diventi consapevole che non è più “la misura di tutte le cose” , “il centro del cosmo”. Mai, come oggi, c’è bisogno di “homines humani” e “politi” da contrapporre agli esseri “indocti et agrestes”. L’uomo “colto” partecipa alla realtà e, a differenti livelli a seconda del suo posto nella società, agisce perché il sapere è conoscenza in azione. L’educazione permanente promuove il “senso perenne della ricerca” che deve avere come fine l’auto-educazione. E’ necessario, quindi, sviluppare, la capacità di “apprendere ad apprendere” perchè la scuola adatta alla società in cui viviamo deve insegnare ad imparare fuori della scuola e senza la scuola, per tutto l’arco della vita, attraverso un processo ininterrotto di aggiornamento e sviluppo delle proprie conoscenze, tale da favorire la possibilità di autonomo controllo e progettazione di intervento sul contesto di vita e di lavoro individuale. E’ l’educazione che prepara gli individui a partecipare ai cambiamenti di una società sempre più complessa e le assicura i vantaggi di un vasto potenziale di intelligenze, di talenti, di energie. Nello stesso tempo, il progresso dell’educazione promuove il miglioramento delle relazioni tra i popoli contribuendo a instaurare uno spirito di comprensione e di pace internazionale e l’avvento di un nuovo ordine mondiale fondato sulla giustizia e la solidarietà.
L’esperienza dei Centri di Cultura Popolare ha avuto risonanza mondiale e i Centri sono diventati meta di numerosi studiosi, esperti e responsabili dei vari paesi, borsisti dell’UNESCO, dell’ONU e di Paesi del Terzo Mondo, per stages pratici di aggiornamento. Con il Centro di Cultura Popolare, come sappiamo, la lotta contro l’analfabetismo veniva legata all’educazione degli adulti e considerata momento di questa, in anticipo di 10 anni rispetto a quanto sarà codificato nella conferenza di Montreal, realizzando, secondo l’UNESCO, il legame alfabetizzazione educazione permanente, una sintesi culturale adatta a rispondere ai bisogni delle popolazioni e alla loro partecipazione al rinnovamento della società. Dal 4 al 6 aprile 1951 si tiene a Roma il “Convegno Internazionale sull’educazione degli adulti indetto dall’UNLA con il patrocinio dell’UNESCO e del MPI, Convegno che di colpo portò l’Italia al ruolo di guida di quella che verrà chiamata “l’Educazione Permanente”. Finito il Convegno, l’UNESCO riconobbe l’UNLA “Organizzazione per progetti associati”.
Nella sua molteplice attività, la prof.ssa Anna Lorenzetto, in veste di consulente di vari organismi Internazionali e autrice dei Rapporti alle Missioni effettuate per conto dell’UNESCO, quale membro di rilievo viene incaricata, in occasione della campagna di alfabetizzazione di Cuba di condurre uno studio sul progetto cubano. Il Rapporto sulla Campagna di Alfabetizzazione a Cuba, fu redatto da A. Lorenzetto e adottato come Rapporto Ufficiale dal Governo Cubano.
La campagna di Alfabetizzazione a Cuba, voluta da Fidel Castro nel 1961, rappresenta uno degli eventi educativi di maggior rilievo dei nostri tempi, un evento che i Cubani rivendicano come il più rivoluzionario dopo la rivoluzione stessa, iniziata il 1 gennaio del i961, anno che prese il nome di “Anno dell’Educazione” il 22 Dicembre 1961 Fidel Castro proclamò solennemente Cuba “Territorio libero dall’Analfabetismo”. La grande campagna era finita. Cominciava, a Cuba, il “seguimiento” e la superaciòn “obrera i campesina”.
Nella Monografia sulla Campagna del Municipio de La Habana possiamo leggere: “La Campagna di Alfabetizzazione è stata caratterizzata dall’ampio appoggio che incontrò in tutta la popolazione cubana, dai bambini agli anziani, dagli operai ai contadini, dalle donne agli studenti, tutti si disposero ad insegnare a leggere e scrivere alla parte della nostra popolazione che ancora non aveva accesso alla cultura. Non solamente insegnarono a chi non sapeva, ma anche contribuirono economicamente affinché la Campagna di Alfabetizzazione fosse in grado di offrire il materiale ncessario: libretti, matite, lavagne, gessi, affitti di locali, pagamento dell’energia elettrica, aiuto economico a coloro che dovevano lasciare le loro occupazioni per imparare a leggere e scrivere….”.
“Que todo analfabeto tenga alfabetisador. Que todo alfabetisador tenga analfabeto “Questa la formula magica lanciata da Fidel Castro.
Una caratteristica della Campagna di alfabetizzazione cubana furono gli inni e le poesie. Fra le molte poesie, vorrei ricordare “Despertas” Di Edoardo Saborit che fu anche musicata e cantata in tutta l’isola.
Risveglio
Quante cose posso ora dirti
perché finalmente ho imparato
a scrivere.
Ora posso dirti che ti amo.
Ora si te lo posso dire…
Sulla quiete sabbia del fiume
e sul tronco di quell’albero
sto scrivendo il tuo nome e il mio
che uniti per sempre saranno,
io sapevo leggere nei tuoi occhi
ciò che la tua anima mi voleva dire
ora posso leggerlo nelle tue lettere
ora comincio, amor mio, a vivere.
Perchè la patria mi ha dato n tesoro,
ho imparato a leggere e scrivere.
Despertas
(Cuantas cosas ya puedo decirte / porque al fin he aprendito / a escribir. / Ahora puedo decir que te qulero, / ahora si te lo puedo decir… / En las quietas arenas del rio / y en el tronco de aquel fromboyàn /voy ponlendo tu nombre y el mlo / que enlazados por slempre estaràn. / Yo sabis leer en tus ojos /lo que tu alma me queria decir / ahora puedo leerlo en tus cartas / ahora empiezo, mi amor a vivir. / Ya la patrla me ha dado un tesoro, / ha aprendido a leer y escribir).
Prof.ssa Alba Pugliese, Dirigente del C. C. E. P “Raffaele Carnevale” via A. Serra 93/b Roma e Referente Archivio Storico UNLA