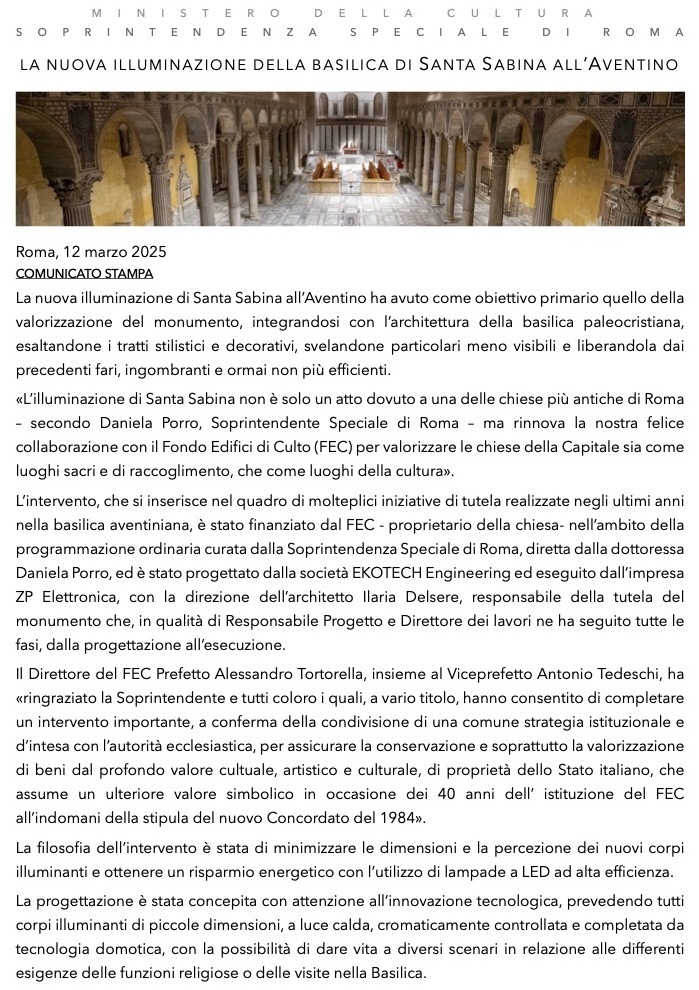(AGENPARL) - Roma, 12 Marzo 2025
(AGENPARL) - Roma, 12 Marzo 2025(AGENPARL) – mer 12 marzo 2025 L A N U O VA I L LU M I N A Z I O N E D E L L A B A S I L I C A D I
S A N TA S A B I N A A L L ’A V E N T I N O
Roma, 12 marzo 2025
COMU NI CATO STA MPA
La nuova illuminazione di Santa Sabina all’Aventino ha avuto come obiettivo primario quello della
valorizzazione del monumento, integrandosi con l’architettura della basilica paleocristiana,
esaltandone i tratti stilistici e decorativi, svelandone particolari meno visibili e liberandola dai
precedenti fari, ingombranti e ormai non più efficienti.
«L’illuminazione di Santa Sabina non è solo un atto dovuto a una delle chiese più antiche di Roma
– secondo Daniela Porro, Soprintendente Speciale di Roma – ma rinnova la nostra felice
collaborazione con il Fondo Edifici di Culto (FEC) per valorizzare le chiese della Capitale sia come
luoghi sacri e di raccoglimento, che come luoghi della cultura».
L’intervento, che si inserisce nel quadro di molteplici iniziative di tutela realizzate negli ultimi anni
nella basilica aventiniana, è stato finanziato dal FEC – proprietario della chiesa- nell’ambito della
programmazione ordinaria curata dalla Soprintendenza Speciale di Roma, diretta dalla dottoressa
Daniela Porro, ed è stato progettato dalla società EKOTECH Engineering ed eseguito dall’impresa
ZP Elettronica, con la direzione dell’architetto Ilaria Delsere, responsabile della tutela del
monumento che, in qualità di Responsabile Progetto e Direttore dei lavori ne ha seguito tutte le
fasi, dalla progettazione all’esecuzione.
Il Direttore del FEC Prefetto Alessandro Tortorella, insieme al Viceprefetto Antonio Tedeschi, ha
«ringraziato la Soprintendente e tutti coloro i quali, a vario titolo, hanno consentito di completare
un intervento importante, a conferma della condivisione di una comune strategia istituzionale e
d’intesa con l’autorità ecclesiastica, per assicurare la conservazione e soprattutto la valorizzazione
di beni dal profondo valore cultuale, artistico e culturale, di proprietà dello Stato italiano, che
assume un ulteriore valore simbolico in occasione dei 40 anni dell’ istituzione del FEC
all’indomani della stipula del nuovo Concordato del 1984».
Piccoli proiettori, posti in posizione laterale sulle soglie delle finestre, illuminano la navata centrale
e, associati a strip-led collocati centralmente sempre sulle imbotti, danno luce alle transenne
superiori della navata. Il posizionamento dei nuovi apparecchi è avvenuto in corrispondenza delle
fonti di illuminazione naturale, in modo da mantenere – anche in sua assenza – la medesima
provenienza della luce.
L’illuminazione delle navate laterali con faretti di ridotte dimensioni con ottica wide consente una
luce diffusa e uniforme delle strutture lignee e delle navatelle, caratterizzate da un pregevole
pianellato bicromo.
Una specifica illuminazione è stata poi riservata alle cappelle laterali, di Santa Caterina e di San
Giacinto, per evidenziare con una luce morbida e avvolgente, gli elementi decorativi di maggior
rilievo.
Con accentuazioni mirate sono stati evidenziati elementi rilevanti, quali il coro, l’abside, il mosaico
di controfacciata, il campanile nella navata sinistra e infine, nel nartece, la celebre porta lignea
intagliata del V secolo, che conserva una delle prime rappresentazioni della crocifissione.
La filosofia dell’intervento è stata di minimizzare le dimensioni e la percezione dei nuovi corpi
illuminanti e ottenere un risparmio energetico con l’utilizzo di lampade a LED ad alta efficienza.
La progettazione è stata concepita con attenzione all’innovazione tecnologica, prevedendo tutti
corpi illuminanti di piccole dimensioni, a luce calda, cromaticamente controllata e completata da
tecnologia domotica, con la possibilità di dare vita a diversi scenari in relazione alle differenti
esigenze delle funzioni religiose o delle visite nella Basilica.
Infine, sono state sostituite non solo le vecchie lampade, ma tutti i componenti elettrici con la
messa a norma dell’intero impianto, provvedendo anche a una illuminazione di emergenza
attraverso i medesimi corpi illuminanti e al rifacimento dell’impianto audio e di videosorveglianza.
DAL BUIO ALLA LUCE LA NUOVA ILLUMINAZIONE
DELLA
BASILICA
UN PROGETTO DELLA
FINANZIATO
S ANTA S ABINA
ALL’A VENTINO
SOPRINTENDENZA SPECIALE DI ROMA
DA L F O N D O E D I F I C I D I C U LTO
SOPRI NTENDENZA SPECI ALE DI ROMA
Daniela Porro, Soprintendente Speciale
Ilaria Delsere, architetto responsabile del progetto
Giampiero Boato, direttore operativo
Silvia Agostinetto, Comunicazione
Fabio Caricchia, fotografie
Maria Giovanni Zeuli, supporto Rup
FONDO EDI FI CI DI CULTO
Alessandro Tortorella, Prefetto
Antonio Tedeschi, Viceprefetto
COLLABORAZI ONI
Progetto EKOTECH Engineering
Sacha Nocciolini, progettista
Realizzato da ZP Elettronica
Antonio Porcaro
Alessandro Zucca
Luca Ricci, coordinamento sicurezza
U F F I C I O S TA M PA
Luca Del Fra e Valentina Catalucci
L A B A S I L I CA PA L E O C R I ST I A N A D I S A N TA S A B I N A A L L ’ AV E N T I N O
La basilica di Santa Sabina all’Aventino è una delle chiese romane più antiche e, tra quelle
paleocristiane, una delle più conservate nonostante i numerosi cambiamenti, rifacimenti
e restauri avvenuti nei secoli.
Viene fondata nel 425 sotto il pontificato di Celestino I, come riporta l’iscrizione di dedica
nel mosaico della controfacciata, una delle poche parti della decorazione originaria oggi
conservata. Secondo la tradizione, sorgerebbe sopra al Titulus Sabinæ, situato
probabilmente nella casa della matrona Sabina. Le fonti antiche attestano anche la
presenza di un battistero.
Significativi interventi di restauro nella basilica sono documentati tra la fine dell’VIII e gli
inizi del IX secolo, durante i pontificati di Leone III ed Eugenio II, risultando la stessa
inglobata nel X secolo nella fortezza dei Crescenzi e nel XIII nella Rocca della famiglia
Savelli. Nel 1219 un membro di questa famiglia, divenuto papa con il nome di Onorio III,
affida la chiesa a Domenico di Guzmán e al suo Ordine di Frati Predicatori, che la officiano
ancora oggi, ospitando nell’attiguo convento la loro Curia Generalizia. Sempre al XIII
secolo risale la costruzione del campanile.
L’interno viene radicalmente modificato nel 1587, durante il pontificato sistino da
Domenico Fontana e ancora, nel 1643, da Francesco Borromini. L’aspetto attuale della
chiesa si deve ai restauri di Antonio Muñoz, effettuati in due fasi dal 1914 al 1919 e dal
1936 al 1937, con l’intento di riportare la chiesa al suo aspetto originario, liberandola dai
rifacimenti barocchi, di cui restano solo due cappelle laterali dedicate a San Giacinto e
Santa Caterina. E proprio il risultato di questi interventi ha reso alla chiesa l’atmosfera
austera e solenne delle tre navate scandite dalle 24 colonne di spoglio antiche,
appartenute probabilmente a un vicino monumento di epoca tardo imperiale.
La porta dell’ingresso principale risale al V secolo, epoca della costruzione della chiesa,
ed è il più antico esempio di scultura lignea paleocristiana. Nei 18 riquadri conservati, dei
28 che la componevano in origine, sono raffigurate storie dell’Antico e del Nuovo
Testamento, combinate tra loro in modo da simboleggiare la continuità e la
corrispondenza tra la legge mosaica e quella di Cristo.
La decorazione degli interni della basilica in origine doveva probabilmente avere una
forte presenza di mosaici, di cui si conservano solo quelli della controfacciata e un motivo
in opus sectile tra le arcate. Il pavimento è coperto da numerose lastre tombali. In
prossimità del presbiterio è la Schola Cantorum, ricostruita nel 1936 su ispirazione di
quella originaria paleocristiana del IX secolo, anche mediante il reimpiego dei resti dei
blocchi che ne formavano la recinzione, ritrovati alla fine del XIX secolo da Ferdinando
Mazzanti, utilizzati come gradini del presbiterio sistino.
Il catino absidale conserva un grande affresco cinquecentesco di Taddeo Zuccari, in cui
sono state rinvenute tracce dell’antica decorazione musiva, mentre l’arco trionfale venne
dipinto da Eugenio Cisterna nel 1919, basandosi su una tavola seicentesca di Giovanni
Giustino Ciampini che ritraeva il mosaico prima che venisse distrutto nel Settecento. Tra
le pitture si segnalano la Gloria di San Giacinto di Federico Zuccari, fratello di Taddeo, e
la Visione di San Giacinto di Lavinia Fontana, che con Artemisia Gentileschi e Fede Galizia
è stata una delle prime pittrici italiane a ritrarre scene sacre.