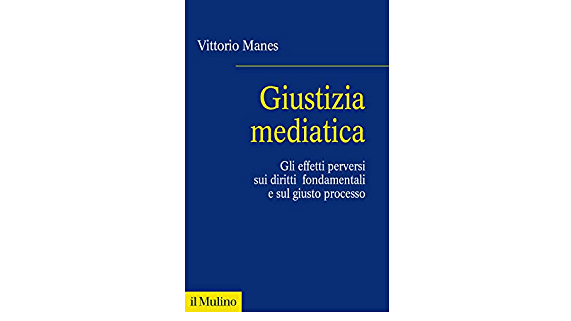(AGENPARL) - Roma, 12 Gennaio 2023
(AGENPARL) - Roma, 12 Gennaio 2023[lid] – Abbiamo rivolto all’avvocato Vittorio Manes, professore ordinario di Diritto penale nell’Università di Bologna alcune domande sull’ultimo lavoro «Giustizia Mediatica» edito da Il Mulino.
Il prof. Manes ha fatto parte di diverse commissioni ministeriali di riforma in materia di giustizia penale, ed ha pubblicato numerosi studi monografici, saggi, articoli e note su tematiche penalistiche.
Domanda. I media hanno trasformato la giustizia in spettacolo. Alto impatto emotivo e a basso titolo di credibilità. Nel suo Libro «Giustizia mediatica» parla addirittura di processo parallelo. Quali sono gli aspetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo. Siamo passati dai «facti» alle fakes?
Manes. E’ vero, la giustizia è diventata “spettacolo”, in molti, troppi casi.
Certo, non è un fenomeno nuovo: parliamo di un problema antico, che tuttavia nei tempi recenti ha registrato – a mio avviso – un salto di qualità degenerativo, anche perché l’informazione – specie nei canali più informali, sui social e nell’infosfera – è sempre più atecnica, non professionale ed informale.
Poi ci sono i talk show, i salotti televisivi, i programmi a metà tra informazione e intrattenimento (i cc.dd infotainment), i documentari a metà tra rappresentazione del reale e finzione (i cc.dd docufiction), tutti strumenti di “spettacolarizzazione” della giustizia penale dove la “cronaca” spesso degenera – appunto – in vero e proprio intrattenimento.
In un simile contesto, bisogna prendere atto che la cronaca giudiziaria e l’informazione giornalistica – anche quella più qualificata – sono guidate da finalità diverse da quelle del processo: domina non tanto l’interesse processuale, quanto l’interesse pubblico su determinati fatti o notizie – anche quelle che nel processo non assumerebbero alcun rilievo giuridico-penale, perché del tutto irrilevanti -, e spesso l’interesse pubblico degenera nella curiosità morbosa verso vicende di vita privata; ancora, e soprattutto, bisogna avere consapevolezza che il catalizzatore dell’informazione è lo share, e quindi l’intento è fornire la notizia accentuando i toni sensazionalistici e gli aspetti più capaci di destare interesse, scuotere i lettori o gli spettatori, magnetizzare l’attenzione, e fare audience.
Questo insieme di fattori produce, necessariamente, effetti deformanti, che allontano la “narrazione mediatica” – una narrazione istantanea, “veloce e frugale”, che non deve rispettare alcuna regola – e la “pseudo-verità” che vi si accompagna da quella lenta e faticosa ricostruzione dei fatti e delle responsabilità che conduce – sulla base di precise regole – alla “verità processuale” nei tribunali.
Domanda. La vittima illustre nell’aula mediatica è la presunzione di innocenza, vero fulcro del processo penale, che viene letteralmente rovesciata. Lei parla dell’indagato come «un colpevole in attesa di giudizio». Insomma come Alice dietro lo specchio, prima la condanna poi il processo. Una liquidazione anticipata del proprio capitale reputazionale che non sarà mai risarcita. Un presunto reo a cui viene pregiudicata la stessa dignità della persona e viene affibbiata una etichetta sociale difficile da dismettere. Tutto questo avviene in un Paese come l’Italia, culla del diritto, e nonostante una costante giurisprudenza della Corte EDU sulla presunzione di innocenza che con sentenze ha ritenuto violato l’articolo 6 §2 CEDU anche a fronte di dichiarazioni che avevano posto il tema non in termini di certezza, bensì in termini interrogativi o dubitativi.
Manes. E’ difficile negare che sull’altare della “giustizia mediatica” la prima vittima sacrificale sia la presunzione di innocenza, per diverse ragioni. Anzitutto, l’attenzione mediatica si focalizza – e spesso si esaurisce – in una fase del tutto anticipata del procedimento, ossia nella fase delle indagini preliminari, dominata dalla impostazione accusatoria – ossia dall’ipotesi sostenuta dal pubblico ministero – e veicolata spesso attraverso la pubblicazione – per stralci opportunamente “selezionati” – di atti ai quali non ha partecipato il difensore: basti pensare che la maggior fonte di informazioni, nelle prime “cronache” di un processo, è spesso tratta da una ordinanza applicativa di misure cautelari (una misura cautelare personale o un sequestro), ossia da un atto adottato dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, “inaudita altera parte”, in assenza cioè di ogni contraddittorio con la difesa.
Ciò spiega anche perché, di regola, la narrazione mediatica ha una impostazione colpevolista, che trasforma l’indagato o l’imputato da “presunto innocente” – come vuole la Costituzione e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo – in “presunto reo”, con sacrificio irrimediabile di una garanzia primordiale – la presunzione di innocenza, appunto – posta a tutela del soggetto sottoposto ad un procedimento penale, che deve essere “trattato” come innocente – anche e soprattutto nell’informazione indirizzata al pubblico – sino a sentenza definitiva.
Questo rovesciamento della presunzione di innocenza produce ulteriori effetti perversi, perché il soggetto assoggettato a quella che spesso viene definita “gogna mediatica” – ossia la “esibizione pubblica” di colpe e responsabilità ancora da accertare -, subisce una sorta di ustionante “scomunica” collettiva, che si traduce in una autentica capitis deminutio e spesso in un immediato esilio dal consorzio civile: carriere politiche bruscamente interrotte, attività professionali e imprenditoriali profondamente incise e – spesso irrimediabilmente – pregiudicate, rapporti lavorativi, familiari ed affettivi compromessi.
Il problema è aggravato dal fatto che tutto questo non trova alcun rimedio o ristoro anche quanto il processo – magari dopo molti anni – esiterà in una assoluzione, ed anche se il soggetto verrà assolto per radicale insussistenza dei fatti, cosicché la perdita subita nel “patrimonio” dei propri diritti fondamentali da parte del singolo soggetto colpito dall’“ostracismo mediatico” risulterà, di fatto, irrisarcibile: e in gioco non vi è solo la presunzione di innocenza, perché di regola vengono coinvolti e travolti altri diritti personalissimi, come onore e reputazione, appunto, o il diritto al rispetto della vita privata e familiare (dell’indagato come di soggetti “terzi” eventualmente indirettamente lambiti e “coinvolti” – magari in modo del tutto casuale – nella vicenda).
Domanda. Nel suo lavoro «Giustizia mediatica» fa riferimento alle ripercussioni del diritto alla difesa che potrebbero mettere in discussione la più antica virtù che deve contrassegnare lo IUS DICERE, ossia l’imparzialità che viene profondamente alterata nel processo parallelo, minacciando l’equidistanza di chi deve giudicare. In poche parole, la bilancia della giustizia perde il suo equilibrio e la dea sveste la benda che assicura l’imparzialità. E’ palese che in questa cornice per assolvere ci vuole molto coraggio ma anche per derubricare il fatto in un’ipotesi più lieve. Altrettanto chiaro che il primo ad essere influenzato è il pubblico ministero che può sentirsi anzitutto incalzato da parte dei media e ad indurlo a un ricorso abnorme a misure pre-cautelari, come il fermo di indiziati disposto come nel caso avvenuto a Perugia di Meredith Kercher, quasi senza approfondimento di indagine, senza raccogliere e far condensare indizi. Per non parlare del rischio di imboccare frettolosamente una determinata pista investigativa senza valutare con la doverosa e necessaria obiettività il plafond informativo di cui dispone. La giustizia mediatica potrebbe condizionare l’articolo 111 della Costituzione, cioè il giusto processo, dopo la martellante campagna di stampa giornalistica, univocamente orientata propone una versione dei fatti di parte. Anche la Corte di cassazione ha evidenziato sino a stigmatizzare l’incapacità dell’organo inquirente di sottrarsi alle pressioni esterne rilevando che l’inusitato clamore mediatico ha suscitato un’accelerazione nella spasmodica ricerca di un colpevole da consegnare all’opinione pubblica internazionale e non ha certamente giovato alla ricerca della verità sostanziale. Cosa ci ha insegnato la Corte di cassazione sul caso Meredith?
Manes. Le vicende giudiziarie accompagnate da una massiva attenzione mediatica – non solo quella da Lei citata – credo insegnino molto, e ammoniscono tutti in ordine ai rischi di condizionamento che possono alterare le scelte di ogni attore del processo, magistrato inquirente o giudicante, avvocato, imputato e la stessa vittima.
La narrazione mediatica, infatti, crea uno specifico “orizzonte di attesa” nell’opinione pubblica, che non può non condizionare chi compie determinate scelte: potendo arrivare ad orientare o dis-orientare le scelte degli inquirenti, potendo incidere sul comportamento delle parti processuali (imputato e vittima), potendo – soprattutto – contaminare l’imparzialità nella decisione del giudice: e non mi pare affatto convincente, a questo riguardo, la tesi che ritiene il giudice “immune” da condizionamenti, perché protetto – a differenza di “giurati popolari” – dal corredo professionale e tecnico del proprio ruolo che gli consentirebbe di “neutralizzare” ogni possibile influenza distorsiva.
Infatti, mi pare difficile negare che di fronte ad una certa rappresentazione dei fatti – come si è detto, di regola di segno “colpevolista” – ed ad una certa aspettativa diffusasi nell’opinione pubblica, il giudice si senta fatalmente chiamato “a dire da che parte sta”: se sta dalla parte, appunto, della “pseudo-verità mediatica” e della vox populi che reclama a gran voce – o “a furor di popolo” – la condanna, o se, invece, sta dalla parte di imputati che l’opinione pubblica ha già giudicato colpevoli.
Di questa influenza, spesso subliminale e inconsapevole, è naturalmente difficile dare prova empirica; ma in non pochi casi sono gli stessi magistrati coinvolti in vicende giudiziarie che hanno magnetizzato l’attenzione dei media a riconoscere, magari dopo molti anni, di aver avvertito più o meno pesanti effetti di condizionamento, che ovviamente sono difficili da ammettere, ma che sono facili da sperimentare ex posto se solo si pensa alle reazioni di sdegno delle vittime – o delle “parti civili” – quando un tribunale pronuncia una sentenz adi assoluzione disattendendo le diffuse aspettative di condanna.
Domanda. Nel suo libro parla dei condizionamenti distorsivi che la mediatizzazione della vicenda processuale innesca sul processo reale. La situazione impone una seria riflessione e una vigilanza costante sull’allarmante quadro generale di cui si occupa dell’accertamento dei reati e delle relative responsabilità, ossia di chi è chiamato ad amministrare la giustizia, ma anche da parte degli avvocati?
Manes. Certamente si impone una vigilanza costante anche da parte degli avvocati, e la consapevolezza che un “processo mediatico” presenta caratteristiche diverse, e non di rado una maggior complessità, rispetto ad un processo “ordinario”, proprio in ragione dei condizionamenti che l’influenza dei media può produrre: questa “vigilanza cognitiva” sulle possibili distorsioni può consentire di gestire ed eventualmente neutralizzare i rischi che abbiamo cercato di segnalare.
Nell’esperienza concreta, anche il rapporto con gli organi di informazione che l’avvocato decide di avere – o talvolta è “costretto” ad avere – può presentare aspetti di criticità.
Del resto, in contesti dove l’influenza dei media sulle vicende processuali si è manifestata con particolare frequenza e diffusione, come ad esempio gli Stati Uniti, vi sono avvocati particolarmente esperti e “specializzati” nella “gestione” del rapporto con i media, che spesso affiancano il difensore direttamente investito della causa.
Domanda. Il Garante della protezione dei dati personali e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, cioè alcune Authorities, potrebbero giocare un ruolo fondamentale per riallineare non solo il diritto comunitario a quello nazionale ma soprattutto potrebbero stimolare una risoluzione concreta sul piano della reputation che dovrebbe essere l’obiettivo principale da perseguire in questo contesto. Auspica in definitiva un maggiore controllo delle imprese di editoria e dei gestori di piattaforme – leggasi social media – che veicolano flussi di informazioni di massa? In definitiva meglio il pricing al posto punishing?
Manes. Certo le autorità di garanzia possono dare un contributo importante in questa materia, censurando con maggior fermezza le violazioni dei diritti in gioco, e irrogando sanzioni patrimoniali ove necessario, ma anche imponendo misure di ripristino per garantire – ad esempio – l’immediata rettifica di una informazione scorretta, o per assicurare garanzie effettive per il “diritto all’oblio”, e così via.
In linea di principio, imporre dei costi per le violazioni perpetrate, piuttosto che punizioni ai singoli soggetti che le abbiano commesse, mi sembra una soluzione più convincente e razionale, perché alimenterebbe un maggior controllo – un “onere di organizzazione e controllo” – in capo ai “gestori” e agli “apicali” sui comportamenti dei singoli autori dell’informazione scorretta.
Più in generale, l’auspicio è che si diffonda una “cultura dell’informazione giudiziaria” maggiormente rispettosa dei diritti e delle garanzie dei soggetti coinvolti in una vicenda giudiziaria, una “ecologia dell’informazione” che abbia consapevolezza dei danni gravissimi che la cronaca giudiziaria e il dovere di informare – un dovere necessario ed irrinunciabile in una società democratica, come ogni forma di “libertà di espressione” – possono produrre. E una proposta, a questo riguardo, potrebbe essere quella di sostenere con misure di incentivo pubblico gli organi di informazione – specie i giornali, che da tempo affrontano una preoccupante crisi di vendite – più attenti e impegnati nel rispetto delle garanzie fondamentali dei soggetti sottoposti ad un procedimento penale, così come dei diritti dei terzi “coinvolti” nella vicenda giudiziaria.