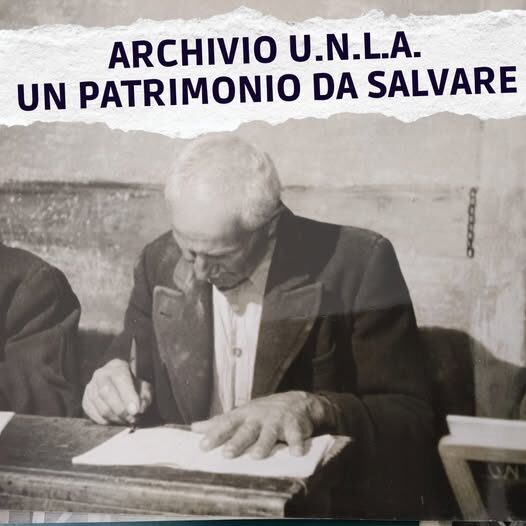(AGENPARL) - Roma, 9 Giugno 2025
(AGENPARL) - Roma, 9 Giugno 2025Presso il Centro di Cultura per l’Educazione Permanente (C.C.E.P.) “Raffaele Carnevale”, situato in via Antonio Serra 93/b a Roma, è custodita una parte fondamentale della memoria documentaria dell’UNLA: un patrimonio di inestimabile valore, un autentico giacimento di storia culturale italiana. L’Archivio dell’UNLA, unificato nelle sue componenti regionali, è stato dichiarato “Archivio di interesse storico particolarmente importante” dalla Soprintendenza Archivistica del Lazio con provvedimento n. 000042129/27 del 2016. Il suo arco cronologico va dal 1945 circa fino al 1990.
L’Archivio conserva le testimonianze di una ricerca e progettualità pedagogica, educativa e culturale senza precedenti nella nostra storia, riconosciute e apprezzate a livello internazionale per lo straordinario contributo offerto al dibattito sulla crisi dell’educazione e all’evoluzione del concetto di educazione permanente in una società in continuo cambiamento.
L’UNLA (Unione Nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo) è un’associazione con finalità educative, nata nel dicembre 1947 grazie all’impegno appassionato di grandi “Maestri” – come li definì Maria Montessori – tra cui Saverio Nitti, Salvatore Valitutti, Arangio Ruiz e la stimata pedagogista Anna Lorenzetto. Erano convinti che solo liberando, attraverso l’educazione, l'”Humanitas” presente in ogni essere umano, si potesse sperare in una società più giusta, più libera, più pacifica: una pace non fondata su soli accordi politici ed economici, ma soprattutto sulla cultura e sull’educazione.
Nel 1948, l’Assemblea Generale dell’ONU adottò la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, che riconosce l’istruzione come diritto fondamentale. A quel tempo, quasi un miliardo di persone – oltre la metà della popolazione mondiale – erano analfabete: un’umanità muta, indifesa, incapace di comprendere il mondo, facile preda del potere. L’analfabetismo, al pari della fame e della povertà, era (ed è) una condizione moralmente inaccettabile, in contrasto con i diritti fondamentali. L’alfabetizzazione, al contrario, rappresenta uno strumento essenziale per la trasformazione sociale, lo sviluppo economico e la comprensione tra i popoli.
L’istruzione ha una doppia funzione: da un lato garantisce continuità e trasmissione del sapere, dall’altro favorisce il rinnovamento, fornendo le competenze necessarie al progresso delle società. Le grandi conferenze internazionali dell’UNESCO – Elsinor, Montreal, Teheran, Tokyo – hanno definito il concetto di educazione permanente come una necessaria continuità e globalità degli interventi educativi in una società che cambia.
Nel programma di alfabetizzazione globale promosso dall’ONU e affidato all’UNESCO, l’Italia ha svolto un ruolo di primo piano. Il lavoro dell’UNLA, in particolare, è stato ampiamente riconosciuto e apprezzato a livello internazionale, al punto da diventare l’associazione più studiata e visitata in Europa. Il suo progetto educativo, radicato in un Mezzogiorno segnato da arretratezza, povertà, malaria e soprusi storici, rappresentava una concreta speranza di riscatto.
L’UNLA ha dimostrato come l’analfabetismo fosse non solo un problema culturale, ma anche sociale ed economico, alimentato da secoli di ingiustizie e sfruttamento. L’impegno per l’alfabetizzazione, dunque, si intrecciava con le battaglie per la giustizia sociale, come quella per la redistribuzione della terra. Con il tempo, l’associazione ha suscitato grande interesse anche tra studiosi stranieri, sociologi e antropologi, grazie a un metodo educativo integrato con lo sviluppo sociale.
Nel Congresso Mondiale di Teheran del 1965, la relazione italiana sull’educazione degli adulti, presentata dalla prof.ssa Anna Lorenzetto e riconosciuta ufficialmente come “Tesi italiana“, suscitò grande interesse e fu tradotta in varie lingue, tra cui l’arabo e il vietnamita.
L’UNLA ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui:
- il Premio “Antonio Feltrinelli” dell’Accademia dei Lincei per l’alto valore morale e umanitario dell’opera svolta;
- il Premio “Nadejda Kroupskaia” e il Premio “Reza Pahlavi” conferiti dall’UNESCO per l’efficacia delle attività pratiche e il contributo concettuale offerto a livello internazionale;
- la Medaglia d’Oro ai Benemeriti della Scuola, della Cultura, dell’Arte nel 1977.
La prof.ssa Lorenzetto, oltre ad essere presidente dell’UNLA, è stata consulente di numerosi organismi internazionali e ha prodotto molti rapporti sulle missioni effettuate per conto dell’UNESCO, tra cui quella a Cuba.
Nel 1962, presso il Palazzo della Civiltà del Lavoro, si svolse il Convegno “Alfabeto e Società“, alla presenza delle più alte cariche dello Stato e di rappresentanti dell’UNESCO e dei corpi diplomatici. I materiali raccolti in questa occasione servirono alla redazione del Repertorio mondiale dell’analfabetismo e dell’alfabetizzazione, ancora oggi un documento fondamentale.
La sede scelta per il convegno – Roma – simboleggiava il riconoscimento internazionale all’Italia per i suoi metodi educativi innovativi. I centri sociali dell’UNLA vennero scelti come istituti pilota in molte regioni di Africa e Asia. La posizione geografica e la politica culturale dell’Italia la resero ponte ideale tra Europa e paesi in via di sviluppo.
Due documentari di Michele Gandin, Cristo non si è fermato a Eboli (1953) e Non basta solo l’alfabeto (1959), vinsero il Gran Premio alla Mostra Internazionale del Documentario di Venezia, descrivendo la realtà dei territori dove l’UNLA operava.
Nel 1950 nacque la Cassa per il Mezzogiorno, ma fu solo dal 1963 che iniziarono finanziamenti stabili per l’UNLA. I Centri di Cultura Popolare divennero così strumenti di sviluppo sociale e culturale, parte di una nuova idea di “meridionalismo”.
Anche la Chiesa e la Radio-Televisione italiana contribuirono al dibattito sull’educazione. La trasmissione “Non è mai troppo tardi”, con il maestro Alberto Manzi, e i corsi di “Telescuola”, avviati alla fine degli anni ’50, furono strumenti fondamentali per la diffusione dell’istruzione.
Il Centro di Tor di Quinto, oltre alla biblioteca, offriva corsi per il conseguimento della licenza elementare e media, corsi professionali per stenodattilografe, corrispondenti commerciali, operatori turistici, telescriventisti, operatori museali. Il quartiere, un tempo povero e isolato, subì una profonda trasformazione urbanistica e sociale, documentata fotograficamente, fino a diventare la residenziale Collina Fleming. Quando gli abitanti furono espulsi dalla speculazione edilizia, i corsi continuarono nelle borgate di Roma Nord, con sezioni staccate anche presso gli ospedali Forlanini e Santa Maria della Pietà.
La ricchissima biblioteca d’archivio conserva materiale a stampa e periodici in più lingue, su tematiche educative e relazioni con enti internazionali.
L’Archivio dell’UNLA rappresenta una risorsa unica per studenti, ricercatori, educatori, offrendo potenzialità educative, pedagogiche e didattiche fondamentali per comprendere criticamente la storia, analizzare fonti, studiare trasformazioni sociali e culturali avvenute dal dopoguerra a oggi.
Negli ultimi anni si è intensificato l’interesse per l’eredità dell’UNLA. Nonostante le numerose ricerche, la sua storia merita ulteriori approfondimenti per restituire un quadro culturale e politico più articolato.
Un capitolo importante riguarda la collaborazione tra UNLA e l’organizzazione quacchera American Friends Service Committee (AFSC), vincitrice del Nobel per la Pace nel 1947. Il sostegno dell’AFSC all’UNLA, avviato nel 1949, si concluse nel 1962, dopo oltre un decennio di collaborazione proficua.
L’Archivio UNLA è un bene comune, una memoria preziosa della nostra identità culturale, una risorsa per progettare il futuro. Come recita il preambolo dell’Atto Costitutivo dell’UNESCO, adottato a Londra il 16 novembre 1945:
“Poiché le guerre nascono nella mente degli uomini, è nella mente degli uomini che devono essere costruite le difese della pace.”
Una pace fondata sulla cultura e sull’educazione, non solo su accordi politici.
Prof.ssa Alba Pugliese, Referente Archivio Storico U.N.L.A di via Antonio Serra, 93/b.