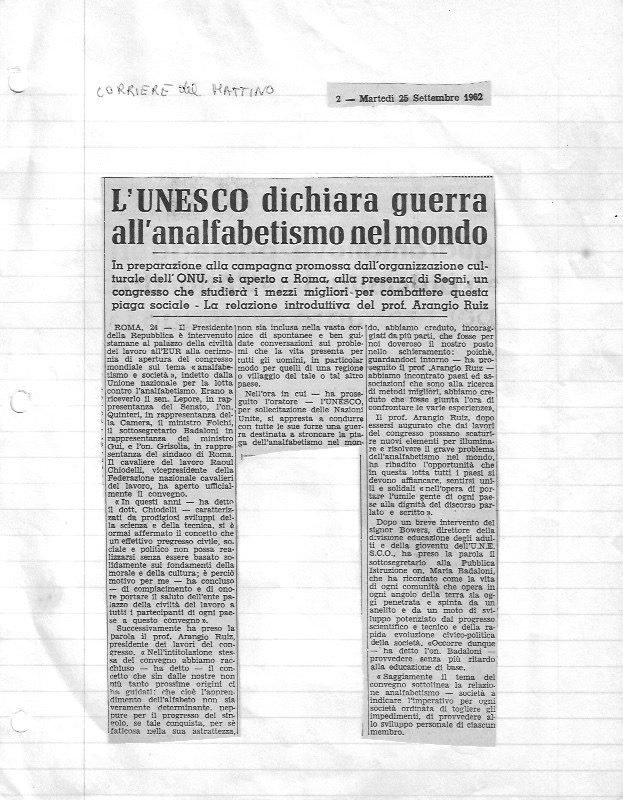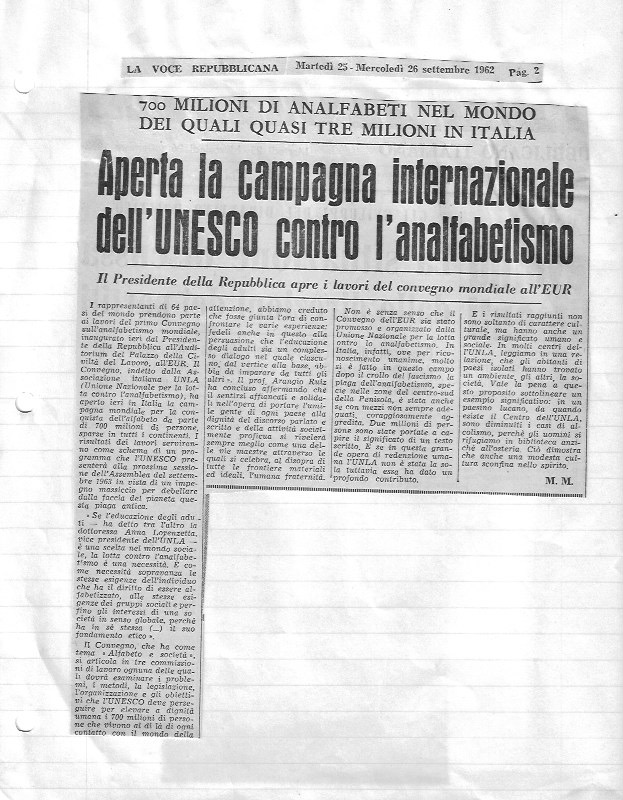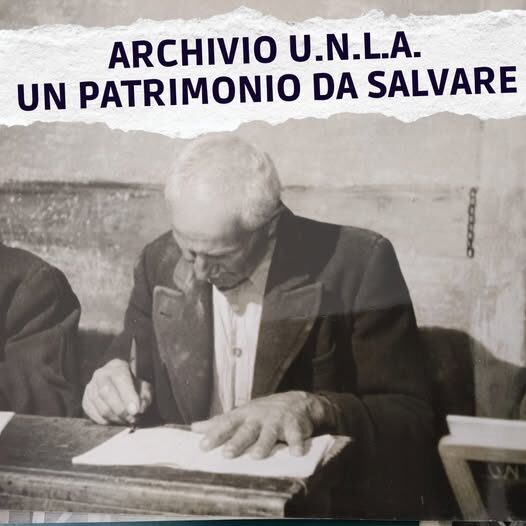(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2025
(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2025L’8 settembre, Giornata Internazionale dell’Alfabetizzazione, ci invita a riflettere sull’impatto profondo che la lotta contro l’analfabetismo ha avuto e continua ad avere sulla società. Non si tratta solo di saper leggere e scrivere; è un percorso di emancipazione che trasforma l’individuo da mero “suddito passivo” a “cittadino responsabile”. Questo riscatto dal pauperismo intellettuale, spesso più doloroso di quello economico, è stato l’obiettivo primario di un movimento di straordinaria importanza nel dopoguerra italiano: l’UNLA (Unione Nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo).
La nascita e il contesto storico: un’Italia da ricostruire
Fondata il 2 dicembre 1947, l’UNLA emerse in un’Italia devastata dalla guerra, dove il 13% della popolazione era analfabeta. Guidata da figure di spicco come Saverio Nitti e la pedagogista Anna Lorenzetto, l’iniziativa andò oltre il tradizionale approccio scolastico. I Centri di Cultura Popolare, come il primo aperto a Roma nel 1948, erano concepiti come ecosistemi educativi polifunzionali. Oltre a insegnare a leggere e scrivere, offrivano laboratori di tipografia e officine, fornendo competenze professionali concrete, immediatamente spendibili. L’UNLA partiva da una convinzione fondamentale: il sottosviluppo non era solo economico, ma affondava le radici in problemi di cultura, educazione civica e democratica. I Centri di Cultura Popolare erano un punto d’incontro tra l'”alfabeto minore” (leggere e scrivere) e l'”alfabeto maggiore” (la conquista del sapere, del lavoro e della cultura), un’impronta internazionale unita a una profonda democrazia diretta e radicata nel territorio locale.
L’Educazione permanente: una visione rivoluzionaria
L’azione dell’UNLA ha rappresentato il primo esperimento italiano di educazione permanente, una concezione rivoluzionaria per l’epoca. Questa visione, ispirata ai principi dell’Umanesimo, vedeva l’educazione come un processo che dura tutta la vita, con l’obiettivo di superare la passività intellettuale. Non si trattava più di trasmettere nozioni, ma di promuovere la capacità di “imparare ad apprendere” e rendere l’uomo consapevole di non essere più “la misura di tutte le cose”. Questa pedagogia della vita interiore mirava a formare “homines humani et politi”, ovvero uomini colti che partecipano attivamente alla realtà, in contrapposizione agli esseri “indocti et agrestes”. Il sapere diventa così “conoscenza in azione”.
Riconoscimento internazionale e contributo globale
L’esperienza dei Centri di Cultura Popolare dell’UNLA non passò inosservata. Divennero una meta per studiosi da tutto il mondo, fungendo da “istituti-pilota” per progetti di alfabetizzazione in Africa e in Asia. Con il Convegno Internazionale sull’educazione degli adulti del 1951, patrocinato dall’UNESCO, l’Italia si impose come guida nel campo dell’educazione permanente. Il ruolo dell’Italia fu ulteriormente rafforzato da figure come Vittorino Veronese, Direttore Generale dell’UNESCO, e, in particolare, da Anna Lorenzetto. Come consulente internazionale, Anna Lorenzetto portò l’esperienza dell’UNLA a livello globale, tanto che il suo studio sulla Campagna di Alfabetizzazione di Cuba del 1961, voluta da Fidel Castro, dimostra l’impatto e la risonanza del modello italiano. La formula cubana “Que todo analfabeto tenga alfabetisador. Que todo alfabetisador tenga analfabeto” riecheggiava la filosofia di partecipazione popolare promossa dall’UNLA.
L’eredità dell’UNLA e la sfida del presente
Nel 1962, il Convegno mondiale “Alfabeto e Società” a Roma, organizzato dall’UNLA, pose le basi per la campagna mondiale di alfabetizzazione dell’ONU e dell’UNESCO. L’evento dimostrò che l’Italia non solo aveva affrontato con successo la piaga dell’analfabetismo, ma aveva sviluppato metodi innovativi che andavano oltre la semplice istruzione, puntando all’inserimento sociale. L’UNLA ha lasciato un’eredità preziosa: una concezione dell’educazione come processo di liberazione e partecipazione attiva. Oggi, in un’epoca di nuovi “analfabetismi” (digitale, economico, emotivo), l’azione dell’UNLA ci insegna che il riscatto intellettuale non è solo un dato statistico, ma una costante ricerca di nuovi saperi e linguaggi per superare le barriere della passività e dell’ignoranza. Educare alla pace, alla solidarietà e alla comprensione interculturale resta, proprio come allora, un compito primario per l’umanità.
Riconoscimenti internazionali
L’impegno dell’UNLA ha avuto un grande eco internazionale, diventando un esempio da seguire e un modello di studio. A testimonianza del suo operato, l’associazione e i suoi membri hanno ricevuto importanti riconoscimenti:
- 1958: Premio “Antonio Feltrinelli” dall’Accademia dei Lincei.
- 1970: Premio “Mohamed Reza Pahlavi” dall’UNESCO al dirigente del Centro di Cultura Popolare di Santulussurgiu.
- 1977: Premio “Nadejda K. Kroupskaia” dall’UNESCO all’intera associazione. Nello stesso anno, Anna Lorenzetto viene insignita della Medaglia d’Oro ai Benemeriti della scuola, della cultura e dell’arte.
Nel 1965, al Congresso Mondiale dei Ministri dell’Educazione a Teheran, la relazione di Anna Lorenzetto “La nuova educazione degli adulti che nasce dall’alfabetizzazione” fu tradotta in diverse lingue e definita ufficialmente “La Tesi Italiana”, consolidando il ruolo dell’Italia come leader nell’educazione permanente.