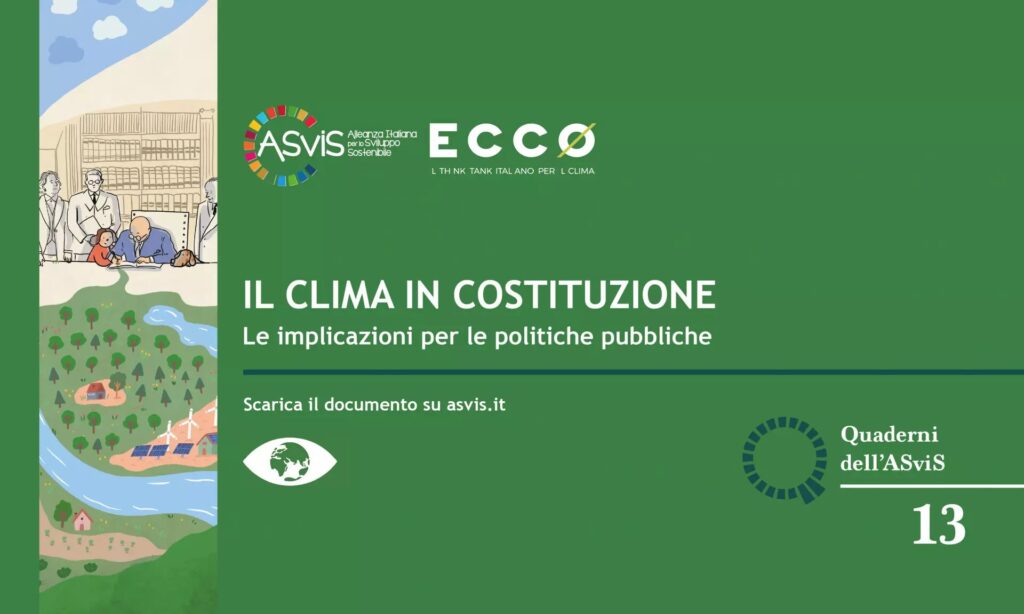(AGENPARL) - Roma, 13 Giugno 2025
(AGENPARL) - Roma, 13 Giugno 2025Come trasformare una modifica costituzionale in una pratica politica e legislativa? Da questa domanda muove il Quaderno “Il Clima in Costituzione”, realizzato dall’ASviS e dalla Fondazione Ecco – Il think tank italiano per il clima.
Il documento, presentato il 21 febbraio all’interno dell’evento “La Costituzione è cambiata: come cambiare l’Italia?”, organizzato presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma in occasione dei tre anni dalla modifica della Carta, rappresenta un importante approfondimento sul significato e sulle conseguenze della riforma costituzionale del 2022 che ha modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana, inserendo la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni.
Durante l’evento è stata presentata anche la campagna multipiattaforma di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla riforma costituzionale che l’ASviS ha realizzato con la Fondazione Pubblicità Progresso.

Un cambiamento di paradigma
Come sottolineato nell’introduzione di Matteo Leonardi, la riforma non si limita a un adeguamento formale, ma segna un cambiamento di prospettiva: la Costituzione diventa un riferimento “ideale e politico di lungo periodo” per l’azione collettiva. L’ambiente non è più un’opzione politica, ma un bene comune da tutelare, secondo principi fondamentali oggi costituzionalizzati.
La riforma, come evidenzia Anna Finocchiaro nel saggio Il tempo che verrà, “comporta il sorgere di un vero e proprio dovere in capo alla Repubblica” e a tutti i suoi attori, incluse imprese e cittadini. Questo segna il passaggio da una concezione estetica a una etica e dinamica della tutela ambientale.
Implicazioni giuridiche e politiche
Secondo Cesare Pinelli, professore di diritto costituzionale, con l’inserimento del tema ambientale tra i principi fondamentali, la Costituzione italiana si pone all’avanguardia rispetto al diritto europeo, affermando che la tutela dell’ambiente deve avvenire “attraverso le politiche pubbliche” e non solo mediante la protezione dei diritti soggettivi.
Uno degli aspetti più innovativi è il principio di equità intergenerazionale, che comporta un dovere costituzionale di protezione delle condizioni di vita delle generazioni future. Questo principio non solo orienta l’azione del legislatore, ma apre interrogativi sulla sua effettiva attuazione: chi può rappresentare gli interessi dei non ancora nati? Quali strumenti giuridici garantiscono la “giuridicizzazione del futuro”, come definita da Anna Giurickovic Dato?
Il ruolo delle istituzioni e delle imprese
La nuova formulazione dell’art. 41 Cost. esplicita che l’attività economica non può recare danno alla salute e all’ambiente, sollecitando imprese e istituzioni a integrare i costi ambientali nelle scelte produttive. Questo significa, come ribadito nel documento, che il mercato da solo non può garantire la transizione ecologica: è necessario un “quadro regolatorio” efficace.
Secondo la Corte costituzionale (sent. 105/2024), l’ambiente non è solo un bene da proteggere nel presente, ma un diritto delle generazioni future. Di conseguenza, ogni deroga alla normativa ambientale deve essere temporanea e giustificata, e non può comportare un abbassamento permanente dei livelli di tutela.
Verso una legge sul clima
Il Quaderno propone l’adozione di una legge sul clima che definisca strumenti normativi, un carbon budget, un consiglio scientifico indipendente e vincoli coerenti con gli impegni internazionali. Inoltre, si propone l’integrazione della spesa pubblica con gli obiettivi climatici e l’introduzione di meccanismi di monitoraggio, accountability e partecipazione.
Il quadro internazionale
Nel contesto globale, il documento analizza casi di contenzioso climatico in diversi paesi (Olanda, Pakistan, Germania), mostrando come i tribunali stiano contribuendo a ridefinire i rapporti tra giustizia, politica e ambiente. In Italia, il primo caso (“Giudizio Universale”) è stato respinto per difetto di giurisdizione, segnalando le difficoltà nell’azionare i nuovi principi costituzionali sul piano processuale.
Conclusione
Il Quaderno ASviS-ECCO invita a una riflessione profonda sul significato della riforma e sulla necessità di politiche pubbliche coerenti, stabili e lungimiranti. L’ambiente diventa un “orizzonte costituzionale”, una sfida collettiva che impone alla Repubblica e alla società intera nuove responsabilità: “trascurare oggi quell’interesse significa ledere domani il diritto di ciascuno”.