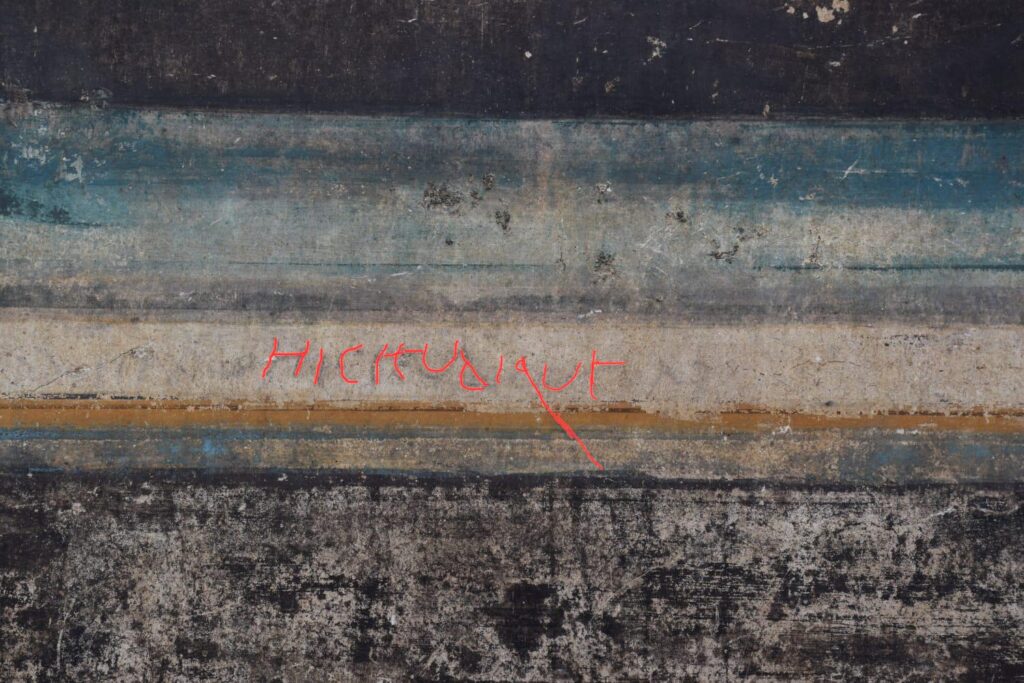(AGENPARL) - Roma, 28 Giugno 2024
(AGENPARL) - Roma, 28 Giugno 2024(AGENPARL) – ven 28 giugno 2024 PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI
E-Journal
Scavi di Pompei
“Hic et ubique”: voci e vite
nel ‘Salone Nero’ (Regio IX, insula 10)
Maria Chiara Scappaticcio 1, Gabriel Zuchtriegel 2
Partiamo da un dato di fatto: come altrove nel mondo romano, anche nella Pompei
primoimperiale a saper leggere e scrivere era
soltanto una percentuale tutt’altro che elevata della popolazione, una percentuale difficilmente quantificabile e sulla quale sarebbe
opportuno focalizzare nuovamente i riflettori
della ricerca. Scrivere era una professione, e i
nobili dettavano, delegando l’atto pratico della
scrittura a professionisti, a scribi, così come delegavano a loro subalterni incombenze di varia
natura. Una firma autografa, però, è segno di
una volontà nella stessa misura in cui un saluto può essere un segno personale. Firme autografe e saluti abbondano sui muri pompeiani:
trovarne di nuovi negli ambienti che emergono
dagli scavi in corso non sorprende. Un nome
o una formula di saluto graffiti o dipinti nel
bel mezzo di una parete, apparentemente senza nessuna ratio, catturano l’attenzione meno
di raffinati dipinti ma hanno una pari e diversa forza comunicativa: i messaggi iscritti sulle
pareti lasciano penetrare in segmenti di vita,
lasciano intravedere gli uomini che vivevano
quegli spazi, ne esprimono il sentire, le velleità, le voci (si veda, per esempio, Scappaticcio
2023, con bibliografia).
Mettere a sistema i brevi segmenti scritti di uno spazio può certamente contribuire
a ricostruirne funzioni e possibili usi: l’esame
contestuale delle scritture pompeiane è quello
che, da una prospettiva archeologica, permette
la ricostruzione di (micro) tessere di storia (per
esempio, Benefiel 2010; Benefiel 2011; Benefiel
2015; Hartnett 2008; Opdenhoff 2019). D’altro canto, un’analisi complessiva delle scritture pompeiane in parallelo a quanto è possibile combinare con l’ulteriore evidenza storica
e letteraria può aprire nuove linee di ricerca in
questa prospettiva, né mancano, infatti, tentativi di ricostruzione della percentuale di scriventi
a Pompei (per esempio, Harris 1983, pp.102111); un’analisi rinnovata, però, si impone alla
luce delle più recenti edizioni testuali e alla luce
di quanto è emerso in corso di scavi più recenti,
e potrebbe guidare a nuovi risultati in termini
quantitativi oltre che, naturalmente, qualitativi.
Anche nel salone dell’abitazione della
Regio IX, insula 10 (Zuchtriegel et al. 2024),
le pareti nere che catturano gli occhi dello spettatore con le raffinate immagini del ciclo troiano recano segni ulteriori di vita vissuta. Sulle
pareti del ‘Salone Nero’, infatti, oltre i nomi
dipinti (in greco) accanto alle rappresentazioni
di Elena e Paride (fig. 1), compare quello ‘graffiato’ di un tale Pudens; nel corridoio 42, quello calligrafico di un Vesbinus, e, ancora, quello
rozzamente segnato da un Valerius, mentre ad
un Silvanus doveva essere indirizzato un saluto
sullo stipite est del corridoio 42, mentre nel vestibolo del sacrarium 31 ci sono tracce di un/
una Modest- (Modestus? Modesta?).
Nella predella della parete sud del ‘Salo-
fig. 1
Università degli Studi di Napoli Federico II
Parco Archeologico di Pompei, Via Plinio 26, 80045, Pompei (NA)
PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI
ne Nero’ (oecus 24) qualcun altro, invece, aveva
dipinto un saluto benaugurante: si tratta di un
augurio formulare, la cui formularità solcherà
i secoli più o meno tacitamente fino ad approdare all’Inghilterra elisabettiana dell’Hamlet
di Shakespeare, e – cosa finora inedita – lo
farà in modo sommerso, senza lasciare tracce
nella letteratura latina coeva e successiva, ma
evidentemente con il medium della preghiera
eucaristica cristiana e con una potenza tale da
dover innescare una più profonda riflessione
sul latino che trova voce attraverso le pareti di
Pompei.
‘What’s in a name?’: Valerius, Pudens,
Modest-, Silvanus, Vesbinus
Il tentativo di capire di più dei nomi che
costellano la città potrà essere meglio radicato
soltanto nel momento in cui verrà compiutamente aggiornata la prosopografia dei pompeiani di Pavo Castrén (Castrén 1975): riallineare
tutti i dati onomastici che emergono dalle scritture pompeiane – si tratti di graffiti, ma anche
di dipinti, di iscrizioni, di tavolette – potrà far
emergere un rinnovato scenario storico dove i
nomi sono espressioni di vite che davano forma
al tessuto sociale della città. Si tratta di un progetto tanto ambizioso quanto necessario che il
Parco Archeologico di Pompei ha in cantiere,
al quale deve fare da complemento un rinnovato studio contestuale dell’intero campionario
scritto pompeiano.
Valerius, Pudens, Modest-, Silvanus: nomi
romani
Valerius, Pudens e Silvanus dicono molto
poco ed hanno come comune denominatore la
loro origine tutta romana. Quanto a Valerius, il
nome, al nominativo, è affiancato da sei aste verticali (le ultime due delle quali leggermente staccate dalle quattro precedenti, e apparentemente
di altra mano) e, poco più in basso, è riprodotto
un fallo. Il nome è inciso, la mano molto poco
abile, ed è copiato nel mezzo della parete nera
del corridoio 42 (fig. 2). Valerio potrebbe aver
scritto il nome da sé, segnando il suo nome e affiancandogli l’indicazione di una quantità (cioè
le sei aste verticali) e auspicando (per sé?) fertilità (cioè la rappresentazione fallica); il nome
di Valerio potrebbe essere stato segnato anche
da qualcun altro che volesse attribuire a Valerio una quantità di qualcosa (che, in assenza di
elementi contestuali evidenti per il fatto che il
nome è scritto su un fondo totalmente nero,
è destinato, per ora, a restare non specificato).
Né è indiscutibile che l’elemento fallico ‘commentasse’ il Valerius o fosse, in qualche modo,
legato ad esso. Rappresentazioni falliche sono
ovunque a Pompei, possono essere benauguranti, possono essere offensive (cfr. Scappaticcio
2018). Valerius è un nomen, espressione di una
gens: la gens Valeria ha, a Roma, origini antichissime che rimontano al VI secolo a.C., ed il
nome Valerio è molto diffuso, anche a Pompei
(sulla gens Valeria resta di riferimento il lavoro di
Münzer 1891; aggiornamenti bibliografici, con
un’attenzione specifica sui repubblicani Ludi
Saeculares, in Dunning 2020). Pudente, invece,
ha semplicemente scritto il suo nome, o meglio,
dopo un primo ed incompiuto tentativo, lo
ha ricopiato per intero: resta, infatti, un Pu- e,
poco sopra, un Pudens. Non si può escludere
che Pudente abbia prima scritto il suo nome
per intero e, poi, ne abbia iniziato una seconda
copia, rimasta interrotta (fig. 3). Ad ogni modo,
Pudente non era abile calligrafo, il suo nome è
inciso a sgraffio, il tratto è inelegante: al nominativo, Pudens – Pudente, ha tutta l’aria di una
‘firma’, l’espressione di un passaggio possibile
fig. 2
PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI
fig. 3
di un uomo in quella casa; l’alternativa, meno
probabile, sarebbe immaginare che Pudente sia
il soggetto di un’azione mai predicata e segnata
dallo scrivente. Pudente è un cognomen (sui cognomina ottenuti a partire da participi, come
nel caso di Pudens, si veda Kajanto 1982, pp.
92-95, lavoro che resta un punto di riferimento insieme a lavori come Solin 1991; Salomies
2008). È attestato a Pompei: Pudente è un libarius “venditore di focacce” (CIL IV 1769, su
cui si confronti di recente Di Stefano Manzella
2017); un L. Aebius Pudens è graffito in modo
isolato su una parete (CIL IV 10185), mentre
di un M. Pollius Pudens si immortalò in un
graffito un atto sessuale (CIL IV 10194a); di
A. Apule(i)o Pudente si sono trovati dei sigilli,
uno dei quali in prossimità del tempio di Iside
(CIL X 8042.017a–c).
Sulla parete est del vestibolo di accesso al
sacrarium 31 si legge il cognomen Modest-, benché complesso sia capire se le tracce successive
alla sequenza più chiaramente leggibile, in parte evanide, siano compatibili con un Modestus
o piuttosto con una Modesta (fig. 4).
Si tratta di un cognomen frequente che,
nato per designare qualità mentali e comune
tra schiavi e liberti (Kajanto 1982, pp. 68-69),
è attestato a Pompei sia al maschile (CIL IV
6610, 6615, 6616 dove si parla di un M. Samellio Modesto candidato edile tra 77 e 79) che al
femminile (CIL IV 4504; 5818). Non lontano
da questo nome graffito si leggono dei segni
numerici apparentemente decontestualizzati
(la sequenza è identificabile come segue: LXIIX, con la possibilità che le due unità –– II ––
siano state aggiunte tra i due decimali).
Silvano al dativo sembra avere un altro
significato. Anche in questo caso un Silvano,
graffito in modo inelegante ma tendenzialmente calligrafico, è ricopiato sullo stipite del
corridoio 42, senza che elementi contestuali
permettano di intendere oltre (fig. 5).
fig. 5
L’uso del dativo fa intendere che lo scrivente (ignoto) indirizzasse qualcosa “a Silvano”,
verosimilmente il suo saluto: se inteso come un
cognomen, Silvano avrebbe potuto essere un
occupante, occasionale o assiduo (o finanche
stabile), di quella casa, ma Silvano è anche un
teonimo. A Pompei Silvanus è attestato come
cognomen di un duoviro (M. Fulvinus Silvanus,
in CIL X 896) e di due consoli (M. Pompeius
Silvanus, in TSulp. 33; 54 e 63; M. Plautius Silvanus, in CIL X 890); il genitivo Silvani si legge
su un’anfora (CIL IV 5899). C’è un dato, però,
che permette di propendere per l’identificazione di un cognomen: anche fuori Pompei ed in
linea con l’uso di nomi divini per cognomina,
fig. 4
PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI
Silvanus è cognomen frequente che potrebbe
tanto alludere alla divinità quanto alla natura selvatica di chi riceveva questo appellativo
(Kajanto 1982, p. 58).
Vesbinus: un liberto imperiale?
Anche Vesbinus è un cognomen e la sua occorrenza nella domus è notevole soprattutto per il
Caesar cui si accompagna. Un Vesbini Caesaris, infatti, si legge nel corridoio 42: con le sue
frequenti apicature ornamentali, la scrittura è
calligrafica, benché graffita, e rivela una rimarchevole capacità scrittoria; le due parole, poi,
sono separate da un punto (figg. 6-7).
Vesbinus è attestato a Pompei, e il cognomen è
evidentemente legato alla campana gens Vesbia
(o Ves(u)via, dal nome del Monte; si veda
Castrén 1983, p. 238, n. 449). D’altro canto,
frequente è che nomi di monti e fiumi abbiano dato origine a cognomina (si veda Kajanto
1982, p. 50).
A Pompei Vesbino è un rogator in un paio di
dipinti elettorali (CIL IV 636, dove compare
come rogator insieme ad un Menecrates; 786);
è cinaedus in un insulto graffito (‘impudente’,
‘svergognato’, e soprattutto ‘effemminato’,
‘checca’, da ????????; si vedano CIL IV 3114
e 2319b); è un adstans, ‘assistente’ che evidentemente aveva supervisionato l’esecuzione materiale di un annuncio gladiatorio (CIL
IV 1190, sul quale si confronti Sabbatini Tumolesi 1980, pp. 52-53, n. 22). In molti casi,
Vesbinus è scritto, al nominativo e talora ripetuto un paio di volte, come nome isolato (per
esempio, CIL IV 2319c; 3116; 8451; 8513b;
8818; 8915d; 9098); talora è in formule di saluto (CIL IV 3115: VIII Vesbinus vale; 6700:
Vesbine copo, vale). L’unico caso in cui di un
Vesbino si conosca il nome completo è quello
di un Marcus Magonius Vesbinus, graffito in
prossimità dell’anfiteatro (CIL IV 8762). Data
la specifica eleganza della scrittura del nostro
Vesbini Caesaris sarà certamente opportuno
un esame paleografico in parallelo a tutte le altre attestazioni pompeiane del nome: se, da un
lato, Vesbino è cognomen verosimilmente comune, dall’altro non si può escludere che uno
stesso Vesbino possa aver vergato il suo nome
in più luoghi (se si tratta, in qualche modo, di
fig. 6
una ‘firma’, dal momento che sussiste parimenti la possibilità che il nome di un Vesbino possa
essere stato iscritto da altri).
L’uso del genitivo è da sottolineare: “di Vesbino
di Cesare”, evidentemente “di Vesbino, liberto
di Cesare”, perché “di Vesbino Cesare” parrebbe da escludere. L’uso del genitivo in nomi
trascritti in modo isolato e apparentemente decontestualizzato è altrove e spesso attestato sui
muri pompeiani (per esempio, CIL IV 4089:
Tiberi Claudi Caesaris; 4222: Caesaris), ed è
allineabile con l’idea di possesso, di ‘sigillo’. Se
“di Cesare” è plausibile che questo Vesbino sia
un liberto imperiale: benché generalmente i liberti imperiali siano piuttosto Caesaris liberti
(per esempio, CIL VIII 12857; cfr. anche i Caesaris servi in CIL VIII 12614; 12629; 12679),
non mancano attestazioni epigrafiche in cui se
ne parli semplicemente come di Caesaris (per
esempio, CIL III 14148.06: “Clonis Caesaris”;
si tratta di un bollo doliare di provenienza egi-
fig. 7
PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI
ziana). Non si può, inoltre escludere aprioristicamente che Vesbini sia un nominativo plurale
(“i Vesbini di Cesare”): si accamperebbe, pertanto, l’ipotesi che un Caesar, un imperatore,
abbia reso liberti più schiavi dallo stesso nome,
appartenenti alla stessa famiglia.
Che sia uno o molti, Vesbino della domus del
‘Salone Nero’, pertanto, sembra identificare un
liberto imperiale, del quale la brevissima stringa testuale non dà di sapere null’altro. Questo
Vesbino potrebbe aver attraversato la domus e
potrebbe aver lasciato egli stesso il suo segno
– nel qual caso bisogna anche riconoscere che
questo liberto imperiale avrebbe avuto notevoli competenze scrittorie –, perché l’alternativa è
che qualcuno, nella domus, abbia, invece scritto
di lui. L’epigrafia rende noto un altro Vesbino
liberto imperiale, il Vesbino liberto di Traiano
che, intorno al 113/114, a Caere (Cerveteri),
chiedeva, all’interno della basilica, un phetrium per gli Augustales, uno spazio specifico
(> ????????, sede di una consociazione messa
sotto la protezione di una divinità; cfr. Calabrò
2005, p. 137;) si veda CIL XI 3614: Vesbino è
chiamato qui Augusti libertus. Di questo Vesbino non si sa null’altro. Si conoscerebbero,
pertanto, due Vesbini liberti imperiali, uno
nella prima età flavia (sotto Vespasiano? o già
in età neroniana?) e menzionato o transitato a
Pompei, ed uno della seconda età flavia, liberto
di Traiano ed attivo in un municipio nell’area
nord di Roma. In questa sede, basti riconnettere l’influenza della figura del liberto imperiale menzionata sulle pareti con le pareti stesse,
pareti di una dimora il cui prestigio è evidentemente espresso a più livelli.
“Hic et ubique”: dalla Pompei primoimperiale all’Inghilterra Elisabettiana
Nella predella della parete sud dell’oecus 24
restano altre tracce di scrittura dipinta (figg.
8-9). Le tracce di questa lunga sequenza sono
pressoché evanide, e soltanto alcune si leggono
con certezza ad occhio nudo. In attesa che se ne
pubblichi l’editio princeps, però, alcuni elementi possono essere messi, fin da subito, in rilievo.
La sequenza ospita certamente un saluto. Questo saluto sembra essere aperto da una data: la
prima lettera leggibile è una X, seguita e ben
distanziata da tracce di lettera compatibili con
quelle di una K, plausibilmente per K(alendas).
Le attestazioni pompeiane di date sulle pareti
fig. 8
PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI
fig. 9
si limitano generalmente al numero, all’indicazione di Idi, Calende o None, al nome del
mese (che ci si aspetta anche nel nostro caso,
dunque), e mai sono completate dall’indicazione dell’anno.
Dopo l’indicazione del giorno (X) e
quella (possibile) delle calende (K) ci sono
c.15–18 lettere soltanto parzialmente leggibili
seguite dalla sequenza hic et ubique: è questo
l’elemento-chiave che permette di riconoscere
nel messaggio dipinto nella zoccolatura inferiore della decorazione parietale un saluto